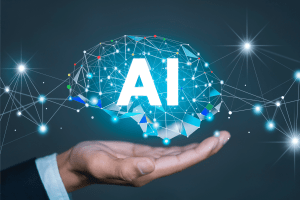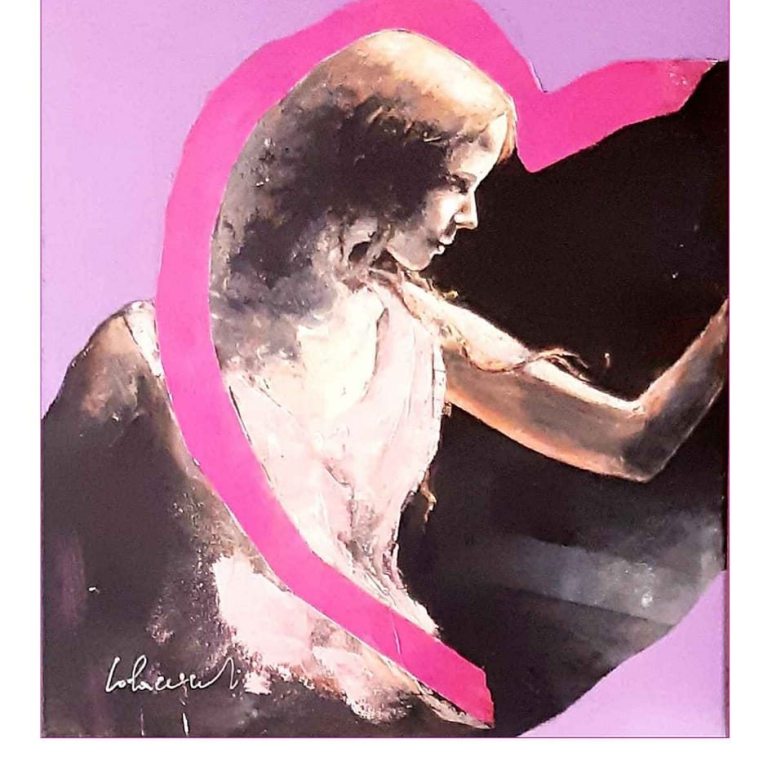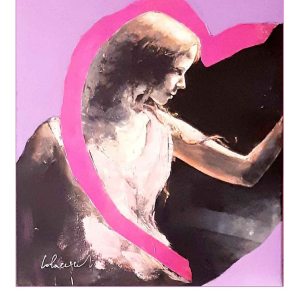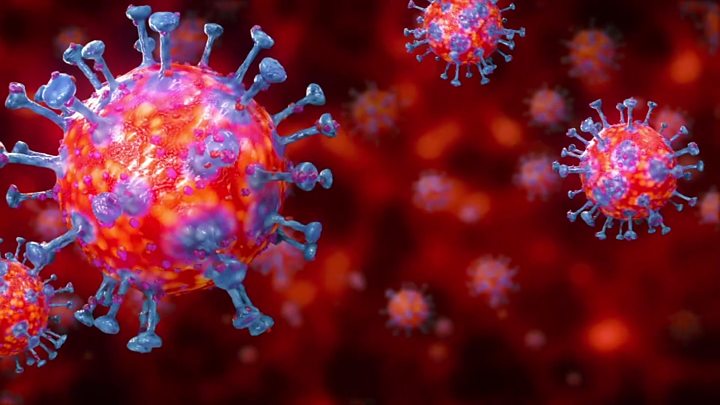di Eddo Della Pietra

In mezzo al frastuono mediatico e rumore di fondo da tv e smartphone che riempie ormai da molti anni ogni nostra giornata saturandoci gli occhi e le orecchie, parlare di regali natalizi sembra oggi avere ormai ben poco senso. Infatti, in questa nostra società occidentale, per una considerevole fetta della popolazione, ogni giorno dell’anno può essere buono per compere e regalie; per se stessi o per gli altri. Ciò mentre in luoghi più sfortunati, neanche troppo lontani, per guerre e crudeltà di cui solo l’uomo è capace, si lotta e si combatte anche a Natale per un pezzo di pane nella miseria più assoluta e desolante, provocata da dittatori senza scrupoli che dominano i popoli, imperversando e massacrando; facendo morire con le bombe o d’inedia, perfino bambini innocenti. Qui da noi, invece, l’imperativo è consumare e spendere; con tutte le facilitazioni oggi disponibili; con corrieri che ci consegnano gli articoli ordinati in internet sulla porta di casa nel giro di pochissimi giorni.
Poco importa se questi optional si rivelano poi inutili o quasi; spesso destinati all’interesse di un’ora di bambini o adulti e poi messi da parte, relegati alla polvere. Regali fatti il più delle volte per una diffusa convenzione sociale sull’onda della martellante pubblicità o per non mostrarsi da meno dei nostri simili che fanno bella mostra di aver ricevuto in dono, per le feste, magari l’ultimo modello di cellulare dalle incredibili e strabilianti funzioni e dal costo di migliaia di euro. Poi ci sono le automobili nuove di zecca, che notoriamente rispecchiano un poco anche la personalità dei loro proprietari, per cui se non mettono in mostra l’ultimo modello, si sentono quasi inadeguati a circolare per le vie della loro cittadina. E allora quale regalo natalizio, pagabile a rate, può essere più bello e appagante di un’autovettura di lusso appena uscita dal concessionario? Poco importa in fondo se la famiglia dovrà poi subire delle ristrettezze per molti mesi, fino al saldo del mutuo. Oggi come non mai l’importante a questo mondo è l’apparenza, fisica o virtuale che sia. Importante a tal punto, questo apparire in società, che da qualche decennio è divenuto di moda, specie tra i giovani e giovanissimi, persino l’intervento estetico sul proprio corpo. Ciò nel tentativo di far coincidere l’aspetto consegnato dalla natura, all’ideale che si ha in mente, o all’ipotetico messaggio che s’intende lanciare a chi s’incrocia nelle piazze, nei locali, lungo i marciapiedi, nelle comunità e, naturalmente, sui social. In questi casi si va dal tatuaggio, più o meno esasperato e complesso anche su vaste porzioni di pelle esposta, talvolta con l’aggiunta di anelli e anellini, a veri e propri interventi chirurgici, con tutti i rischi connessi. Tutto per rimodellare il profilo del viso o il corpo in quelle zone in cui l’aspetto non appare soddisfacente o conforme ai modelli in voga. Può essere allora anche questo, oltre alla classica moto di grossa cilindrata o alla prima autovettura, il “regalo” che gli adolescenti chiedono e molte volte ottengono al compimento della maggiore età, o proprio per le feste. Un “contentino” a volte magari nell’idea di poter compensare così, col denaro, il poco tempo loro dedicato dalla super impegnata famiglia odierna in quell’età così problematica e cruciale della vita di ognuno. Quando poi si tratta d’intervenire col bisturi si trova sempre il “chirurgo” senza scrupoli che si presta a farlo senza troppe domande, dietro al fruscio del pagamento in contanti; in ambienti non idonei, sottovalutando i rischi che incombono sull’ignaro giovane paziente.
Se poi malauguratamente le cose dovessero andare storte, la questione diventa un caso di cronaca come quelli che periodicamente si sentono alla tv. Di là da questi casi limite, anche un nome o il disegnino colorato fatto incidere sul braccio o da altre parti, alla prima esperienza sentimentale, perché rimanga regalo per l’anima indelebile negli anni, può costituire in seguito un problema di non poco conto. Ciò evidentemente accade quando si scopre che “ La festa che si credeva appena cominciata, è già finita” per dirla parafrasando l’incipit di una famosa canzone di Endrigo degli anni sessanta. Allora quel nome, o quel grazioso ghirigoro tanto amato, finisce per richiamare solo dolorosi ricordi, e va rimosso; cancellato al più presto per far posto al nuovo sogno, affrontando lunghe sedute con il laser. Una ben complicata faccenda può dunque diventare oggigiorno la scelta di un regalo ideale da mettere sotto l’albero che sia utile davvero a chi lo riceve e non nasconda pericoli; adatto a rappresentare i nostri sentimenti, tenendo conto dell’età e della personalità di chi desideriamo omaggiare. Pensandoci un momento ci si accorge però che in fondo, ciò che conta davvero nei rapporti umani è immateriale, fuori commercio; appartenendo alla parte più nobile dell’animo che ci spinge o ci dovrebbe sollecitare, almeno qualche volta a dedicarci agli altri. E dedicarci veramente a chi si vuole bene o a coloro ai quali dobbiamo riconoscenza, oppure, altruisticamente, ai più bisognosi che incrociamo ogni giorno, significa in primo luogo regalare del nostro tempo. Questa profonda e un poco misteriosa dimensione del nostro vivere che scorre uniforme e senza tregua su tutti gli orologi.

Qualcosa di finalmente uguale per tutti gli abitanti del globo; per i ricchi sfondati come per l’ultimo dei derelitti che si può incontrare nelle degradate periferie delle lontane metropoli, o nell’eterna e dannata solitudine di una cella del carcere. Quale miglior regalo sarebbe dunque una nostra presenza, che riuscisse a mitigare, almeno temporaneamente, il trascorrere delle ore alle persone cui teniamo e per le quali le giornate si trascinano ugualmente amare anche nelle feste, dentro il tunnel della sofferenza fisica o mentale, dove non s’intravede via di uscita? Per questo non sarebbero necessarie compere ai mercatini o ingenti spese per gioielli o altri pacchetti dorati. Il miglior regalo, in fondo, saremo noi stessi; magari semplicemente con due parole e una stretta di mano, cercando di trasmettere un poco di speranza di serenità e affetto. Solo così, aprendo il portafoglio immateriale dell’animo, potremo alleviare anche quelle sofferenze intime che talvolta, quasi per una specie di pudore, non si confidano a nessuno, anche quando gli sguardi raccontano tutto; dolori e difficoltà là dove le lancette dell’orologio avanzano implacabili, senza sorrisi. Allora forse una buona idea sarebbe, almeno per Natale, l’andare a far visita, oltre che agli amici di sempre con cui condividiamo le nostre giornate, anche ai parenti o ai conoscenti che vediamo raramente e che si trovano ospiti nelle Case di riposo, nelle cliniche o in altri luoghi di pena e solitudine, anche domestica. Persone che certamente in cuor loro sperano di vederci arrivare se non altro per scambiare due parole; per dar sfogo magari anche a un liberatorio attimo di commozione, in quel loro isolamento imposto dalle circostanze o auto inflitto. Un’ora del nostro prezioso tempo accanto alle radici della pianta che, nel bene e nel male, ancora ci appartiene; lasciando in disparte altri pensieri o impegni mondani per dedicarci con sincerità al regalo che quel giorno forse rappresentiamo per chi ci attende dietro quella porta e magari conosce un poco anche i nostri travagli. Così, con la nostra semplice presenza, in un certo modo potremo trovare anche noi rifugio accanto alle fronde profumate e pulsanti di luce dell’albero; in quell’ultima sala d’aspetto per niente allegra, che in fondo non si vorrebbe nemmeno frequentare, ma dove siedono silenziosi e senza forze i nostri cari che attendono l’abbraccio e dove ci presentiamo come regalo di poco conto. Confezionati alla buona; senza nastri colorati né fiocchi, ma avvolti nella carta stropicciata e piena di pieghe causate dal notevole cumulo di natali in cui la utilizziamo: sempre quella, che figli, nipoti, i padri, le madri, e gli amici conoscono bene.
Dentro troveranno certamente anche i nostri difetti e manchevolezze, ma intanto avremo nell’animo la segreta speranza di essere ugualmente accettati così come siamo e di sentirci, almeno per qualche ora, di nuovo utili a qualcosa o a qualcuno; rami vivi del secolare tronco che, nonostante tutto, ancora odora di resina. Irrinunciabile metafora natalizia e insieme del trascorrere della vita quindi, il sempreverde abete. Purtroppo, specialmente negli appartamenti delle sterminate città, perfino l’albero di Natale oggi è artificiale; plastico, riutilizzabile; completo di fantasmagorici giochi di luce; di sfere decorate e puntale, con le inodori fronde verdi stampate in fabbrica, inadatte a ospitare sentimenti; pronto per essere piazzato in un angolo dell’elegante salotto ad attendere i pacchetti infiocchettati, come da prassi annuale; basta una spolverata e una presa di corrente e il gioco è fatto. Dov’è finito l’allegro lavorio dei bambini, aiutati dalla mamma e dai nonni, in quelle lunghe e intime serate di dicembre al tepore della stanza riscaldata dallo spolert, attorno al fresco abete appena installato che profumava di bosco? Gli addobbi erano realizzati con quanto c’era in casa: Batuffoli di cotone a simulare la neve; perfino frutta di stagione e cioccolatini con il luccicante involucro di stagnola, si appendevano ai rami con lo spago, per riempire gli spazi. Anche la tradizionale cartolina natalizia, appena arrivata, con le parole di auguri e di nostalgia dei cari lontani si metteva sull’albero, magari tra una stella ritagliata nel cartone e un mandarino. Si comprendeva così facilmente come un semplice pensiero, un augurio sincero fatto col cuore, vale molto più degli ori e degli incensi ostentati pro forma. Torna in mente un’antica leggenda dell’albero di Natale che s’imparava una volta alle elementari: La sera della vigilia la Sacra famiglia si trovava nella grotta mentre gli animali e le piante intorno, a conoscenza che sarebbe nato Gesù Salvatore del mondo, cercavano il modo di presentargli un regalo; un segno di riconoscenza e di affetto. Tutti stavano cercando e trovando qualcosa da offrire al neonato Re per quel giorno speciale: lo scoiattolo due noci, le piante aromatiche il loro profumo; gli altri animaletti se non altro la loro allegra presenza attorno al Bambino deposto nella mangiatoia.
Solo il vecchio e malandato abete, proprio accanto all’entrata si lamentava, agitando al vento la sua chioma sbilenca, di non avere proprio nulla da offrire o da poter mostrare al Signore, a differenza di tutti gli altri. Gesù Bambino, uditi i suoi pensieri, mandò nella notte una nuvola per far cadere la neve sopra i suoi rami, riempiendoli di fiocchi. La mattina di Natale, ai primi raggi del sole, il secolare abete incominciò allora a risplendere come se fosse tutto ricoperto di diamanti preziosi, accesi di luce, presentando al Creatore il suo umile omaggio.